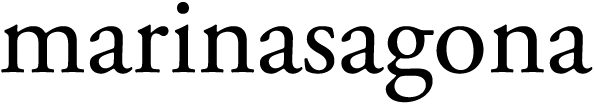Couscous è un video sul rapporto padre-figlia, presente-passato, parole e reticenza, memoria e immaginazione.
Lo schermo appare diviso in due parti, sulla destra vediamo delle immagini dell’archivio della famiglia dell’artista girate a Tripoli nel 1962 mentre la voce del padre spiega la sua ricetta del couscous. Sulla sinistra v’è, invece, un testo in inglese, non la traduzione della ricetta stessa, ma una sua decodificazione emotiva. Usando un dizionario immaginario, l’artista traduce la passione culinaria del padre in una conversazione del tutto nuova e anelata.
Couscous è un condensato sinottico e rivelatore delle tematiche vitali che attraversano la persona - prima ancora che la pratica - di Marina Sagona: le nozioni di controllo, co-dipendenza, trauma e identità condivisa non solo reperiscono la condizione umana in sé ma – con altrettanta puntualità - anche il focus tematico di questa nuova edizione del Festival delle Periferie.
Hic sunt leones, traccia di questa edizione e allusione alle assai antiche carte geografiche manifesto di terre ancora inesplorate, non ancora intaccate dal tempo dell’alienazione e della presunta civiltà occidentale - mi conduce alla discussione ripensando l’immaginario e la memoria come territorio, corpo, limen - colonizzato, violato, liberato, rimosso, co-dipendente - tracciando una mappatura teorico visuale che abbia come oggetto elementi universali nonché costrutti sociali e codici personali, quali: il cibo, la lingua, la casa, l'identità.
Dal titolo stesso dell’opera è possibile scorgere il posizionamento geografico prima ancora che le parole dell’artista fungano da supporto autobiografico. Chiare e leggibili si materializzano le origini libiche del padre dell’artista, Oreste, nato a Tripoli e dichiaratamente figlio di generazioni precedenti in transito, approdate a Tripoli da Malta - durante l’impero ottomano – prima - durante la colonizzazione fascista -poi.
Capitale libica visceralmente Mediterranea, Tripoli, in cui Oreste Sagona abita fino al 1966 per poi trasferirsi a Roma, sua città d’adozione nonché futura città di nascita di sua figlia Marina.
Punto cruciale che non risparmia me dalla menzione; la famiglia Sagona, dal fatto empirico, è la yalaa, la cacciata degli italiani dal territorio libico su comando di quello che fu il regime dittatoriale di Gheddafi, sancendo il definitivo non ritorno degli italiani in Libia e privando di fatto Sagona e la sua famiglia di farne esperienza diretta, collettiva econdivisa.
Mentre Couscous procede e parzialmente racconta, rintraccio un raddoppiamento della condizione esistenziale, un’interezza dissociata ed un chiasmo speculare tra padre e figlia: un padre spartito tra la Libia e l’Italia, Marina, sua figlia, volutamente sdoppiata tra L’Italia e gli Stati Uniti, eleggendo New York come estensione possibile.
Di fronte allo scaraventarsi di un passato che chiede asilo e a ridosso di tale quadro storico, non ho saputo non considerare il profilo di un uomo prima ancora che di padre, che incarnasse il duplice peso storico di colone e profugo, condannato, insieme ad altri italo-libici, ad un defraudamento - probabilmente anche in questo caso duplice - della memoria storica. Un passato migratorio che per eredità, osmosi o replica di controllo, vede Sagona, come citato in Couscous, volutamente lontana per essere libera. Una memoria politicizzata per esistenza, influenzata – invece - per lascito, anche nella rappresentazione artistica delle insite dinamiche relazionali.
Nella circoscrizione dei territori inesplorati, Tripoli rappresenta una geografia non abitata e non esperita direttamente, tuttavia l’inesplorato può - nel caso dell’opera di Sagona - essere declinato e accostato ad un apparente inesplorato stato affettivo, con esplicito riferimento alla relazione padre-figlia di cui questo video è portatore sano.
Una memoria visuale ed un archivio sonoro accompagnano un tentativo pioneristico di rappresentazione ed umana comprensione, non solo di questa Arcadia libica ereditata, anelata seppur mancata ma anche di questo padre, sagoma profondamente indecifrabile, irrimediabilmente avvolta da un’aura di ordinario enigma quotidiano.
Allora Tripoli potrà verosimilmente costituire quella porzione di memoria ed esercizio in cui Sagona e l’inesplorato agiscono come fossero micelio e terra.
Un riferimento quantomeno esplicito al cibo è contenuto a partire dal titolo stesso dell’opera, addensante di un’origine poco fraintendibile ed elemento - nella pratica di Sagona - soventemente dissezionato.
Agente endogeno anche in Ballad of the Feeding Tube, opera altra dove soggetto ed oggetto s’incontrano – questa volta- nella figlia di Sagona.
Il cibo rappresenta in CousCous non solo la breccia ad una comunicazione alternativa ma anche uno dei dispositivi di controllo tramite cui si dispiegano alcune – accuratamente personali - dinamiche relazionali. Come Sagona riporta in Couscous : his silence turns into food, food into nourishment and nourishment into control.
Un’opera – quella di Sagona – in cui un alone di duplice oralità si dispone come soggetto dotato di resistente autonomia: la parola, l'accompagnamento verbale, il senso della nota scritta, la trasmissione, la disposizione; poi l'oralità come alimento, avidità, rifiuto, piacere libidico, comunione, assuefazione, viatico.
Sappiamo bene il cibo essere un profondo attivatore identitario con un ruolo essenziale nella costruzione e nella rappresentazione del sé o delle sue macerie, il cui assumendo una funzione autobiografica e privata dove il gusto funge da metempsicosi di momenti e memento pregressi.
Il cibo cucinato, osservato, introiettato, ingoiato, condiviso o rifiutato, pensato come dizionario o rimosso, racconta di trasformazioni individuali e collettive, costruzioni familiari e codici di convivenza.
In una presa in considerazione del cibo come territorio striato e che per il padre e la figlia di Sagona ha rappresentato indubbio strumento di controllo e manipolazione affettiva, ovunque questo stesso cibo trovi collocazione nella personale esperienza di figlia, madre ed artista, potremmo -forse – far valere l’assunto che siamo ciò che ricordiamo di aver mangiato - o meglio – rifiutato.
In Couscous il cibo si fa altresì linguaggio e possibilità di interpretazione di una – invece - impossibilità radicata di parola. Per l’appunto, mentre sulla destra scorrono in sequenza alcune immagini d’archivio accompagnate dalla voce del padre di Sagona intento a spiegare la sua ricetta del couscous, sulla sinistra vi si affianca un testo in inglese dell’artista, non traduzione pedissequa e letterale della ricetta stessa, piuttosto una personale decodificazione affettiva ed emotiva.
Il linguaggio è - insieme alla casa e al capitale sociale – coordinata e categoria su cui l’uomo s’insinua in un infedele e dunque costante processo di riterritorializzazione, ricreando o sabotando il proprio habitat.
Ancora il linguaggio, finanche trauma come identità mai scisso da sé stesso, al quale Lacan assegna la colpa primitiva di una coatta castrazione di godimento. Allora, la solidità attribuita al linguaggio affiancata alla presunta verità di cui siamo madri e padri putativi, viene – in una qualche maniera – depotenziata nell’opera laddove il linguaggio, la caduta del senso della sillaba è faglia, si rivela in quanto faglia, malgrado la nostra prossimità alla parola; partecipiamo al dire bensì qualcosa resta manifestamente sfuggevole e manchevole. Quest’operazione di decostruzione e ricostruzione di un alfabeto privato in Couscous, ben si ripresenta – sotto simil spoglie – in Ubi consistam, altra opera di Sagona nella quale, in concomitanza all’ottenimento del passaporto americano nel 2017 (primo dispositivo coloniale e di controllo) ed aver – in tale circostanza - sentito la parte italiana della sua identità saccheggiata, Sagona decide di intervenire attraverso la stampa di alcune pagine di tale passaporto, appropriandosi di altrettante esatte parole del documento, sovrapponendoci – infine - le sue iniziali con il tricolore italiano.
Ecco, se per il padre e la figlia di Sagona il cibo ha corrisposto a mezzo di controllo, è assai pensabile che nel caso dell’artista, invece, sia il linguaggio con le conseguenti rappresentazioni di quest’ultimo, ad essere spazio manipolatorio, in un tentativo di riappropriazione e ridefinizione emotivo-territoriale delle sue stesse origini.
Dove stiamo dunque andando? Sempre verso casa è l’epilogo a cui segue il principio; la pacifica collisione tra il non esplorato della traccia tematica del festival e il moto a luogo - verso casa - dell’opera video in questione.
La casa come spazio, suolo fisico e psichico, dialettico e dialogico dove il pensiero dell’uomo – su riferimento deleuziano - muove fra e e per territori, mai oggetto sempre spazio, terra con il quale simpatizzare in vicinanza piuttosto che secondo possesso.
La casa e consequenzialmente il nucleo familiare come primi perimetri sociali in cui si fa esperienza dell’inevitabile e della relazione. Ecco, quel privato a cui sottende il ricordo, quella dimensione accostata al confort o all’ipotesi di riparo, è quello stesso luogo in cui - prima di ogni altro contesto – si innestano meccanismi di controllo, forme di potere, abuso e subordinazione, suggellati da altrettante manovre di auspicata liberazione e indipendenza.
Anche il concetto di casa, come quello di cibo, invoca il privilegio spartendone decori, privazioni o nevrosi i cui brandelli si ricompongono in una maggiore rappresentatività volta - attraverso l’opera di Sagona – a decostruire e disarticolare la - a volte ostentata e semplificante - comodità per conferire dignità ad un non confort come prisma e possibilità di creazione nel reale, un reale considerato nella sua complessità esistenziale.
Tale complessità sociale, storica e politica – in questo caso più specificatamente libica tuttavia estendibile a contesti paralleli – non concede omissioni circa la portata mortifera - da Gheddafi al trattato di Bengasi - della rinnovata complicità italo-libica con gli assai attuali memorandum di contrasto alla vita, non viceversa.
Se la complessità insegna realmente a relativizzare, allora l’immaginazione farà rima con corruzione di una qualche guardia costiera libica e probabilmente Casa - non sarà un paradigma universale o un diritto acquisito - ma l’auspicio di non crepare tra un centro di detenzione ed una porzione di mare.
Tra pretesa e realtà, le pratiche del quotidiano tentano di ricomporre un’integrità spaziale, accatastando geografie e memorie domestiche distanti pur centrate in un corpo medesimo. Puntuali e complici risuonano le parole di J. Bahloul: La casa ricordata è una cosmologia su piccola scala che ripristina l'integrità di una geografia frantumata. Che Sagona sia mai tornata a casa o cosa non lo sia mai stata è un interrogativo incestuoso tra spazio abitato, suolo occupato e assenza prosciolta.
Il cibo, la madre, le nevrosi, il Mediterraneo, i padri, le cellule chimeriche, i figli, tutto quello che pare essere patrimonio collettivo in potenza, che sotto definizione junghiana citiamo come inconscio collettivo, archetipale, si fa questione privata, come un ricettacolo di famiglia che sopravvive in nome dello strappo, condiviso nella pratica, realizzabile nel suo unico farsi. Il dosaggio per fare la vita e disfare i sottintesi in un tempo che vomita e ripete.
Seguitando l’intuizione del festival a questionare l’esistenza di una porzione bianca e radicale di rivoluzione dove l’immaginazione agisca in un assetto del residuo possibile, inequivocabile è il suo disporsi tra libertà e esproprio.
Tale superficie bianca, è custode di una verginità parziale - poco o nulla immacolata - piuttosto sporcata come sporcato è il passaporto di Sagona in Ubi consistam; così come lo è il linguaggio nel tentativo di sorreggere verità assolute destinate a liquefarsi.
Con soluzione di conflittualità - come un focolaio il cui nome proprio chiama il nome dell’altro-da-sé somministrando reciprocità, contaminazione, restituzione e attribuzione di senso - leoni, corpi e spazi terzi sperimentano una convivenza possibile.
Tra contrasto e decentramento di un potere allineato e sorvegliante, la nozione di exforma - è personale pretesto, non casualità – atto a considerare e ripensare l’agglomerato di forme e simbologievita.centralità e marginalità, tra inclusione ed esclusione e – per non predicare omissione - tra riconoscimento e nonriconoscimento, con supplementare allusione alla Palestina.
Nell’esserne - il lavoro di Sagona – testimonianza attiva, nessuno spazio di resistenza può essere abitato senza una soggettività che produca sé stessa in quanto capacità di memoria; una memoria benjaminiana come effrazione nel presente di un’occorrenza dal passato, esautorata da qualsivoglia intento restaurativo, risignificata in un presente dischiuso e vivo, plausibilmente anch’esso diretto verso casa.
Nel tragitto tra residuo ed esistenza, un quesito ennesimo irrompe interpellandoci su cosa resta: di una vita, questa vita.
Tratti da La poubelle agréée, una sequenza di singhiozzi di Calvino citano e contornano in ordine sparso memoria – memoria perduta – il conservare e il perdere ciò che si è perduto – ciò che non si è avuto – ciò che si è avuto in ritardo – ciò che ci portiamo dietro – ciò che non ci appartiene...».
Dove c’è memoria, c’è resto e perdita; quel che rimane, quella parte della vita e della lingua che salviamo dalla catastrofe - come ricorda Agamben - ha senso solo se ha a che fare col perduto. La lingua dell’arte, della poesia, quella lingua volutamente residuale, ci è vicina perché è nel nome della perdita, invoca ciò che si perde, poiché ciò che è sperso è di Dio. Dopotutto - nell’opera - la memoria come atto e attimo di conoscibilità costituisce potenziale esercizio di non possesso tra l’accaduto e il non vissuto.
Memori, spersi e trafficanti si arriva finanche a conclusione, di un epilogo che non nega sé stesso fino a supplicarne replica - come il ritorno a casa – ammissibile solamente attraverso le ultime sei parole del componimento dal titolo Niente del siciliano B. Cattafi: la memoria è sempre un contrabbando.